MASSONI PAVESI
A
B C D E F G H I L M
N O P Q R S T U V Z
A
ARAGONA ANTONIO
Negoziante, droghiere, nel 1873 fu tra gli ispiratori di una Società di Mutuo
Soccorso fra droghieri includendo non solo i padroni ma anche i commessi di
negozio; nello stesso anno fu tra i firmatari, insieme ad altri massoni:
Antonio Griziotti, Giulio Turati e Gaetano Manelli, di una lettera contro i
Gesuiti e contro l’inattività della Sinistra. Nel 1884 appare fra gli
amministratori della Società Operaia Edificatrice, una società per azioni a
cui aderirono numerose società popolari, banche e molti privati, tale società
si fuse, nel 1895, con la Banca Operaia di Mutuo Credito, dando origine alla
Banca Cooperativa Pavese. Membro del comitato direttivo della Società
democratica e reduci. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il
titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.
B
BALDI
Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.
Membro della Loggia "Cardano"
BAGINI LUIGI
Farmacista,
assessore nel 1905.
BERETTA CAMILLO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
BERETTA EMILIO
Repubblicano, membro della Società Democratica; nel 1887 entrò, con altri
massoni, Guido Gnocchi, Urbano Pavesi e Antonio Grizzotti, nel comitato per la
costituzione del ricreatorio laico festivo di Pavia. Membro della società
operaia di Cura Carpignano. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con
il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.
BIDOIA VITTORE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
BIZZONI ACHILLE
Fra i fondatori del giornale “La Provincia Pavese” insieme a Contardo Montini
e Costantino Mantovani (fratello di Giuseppe Mantovani, maestro venerabile
della Loggia Pedotti.
BOERCHIO ABELE
Radicale. Fu tra i piú assidui collaboratori di Contardo Montini
fondatore del giornale “La Provincia Pavese” che nel 1906 ne acquistò la
testata e la diresse a partire dal 1907 fino a che, avendo deciso di occuparsi
solo dell'attività editoriale, volle affidarne la direzione al dott. Carlo
Ridella (massone), la reazione era in Corso Mazzini 6; entrò nella Loggia
Cardano nel 1910 in seguito anche Maestro Venerabile della stessa.
BORDINI GETANO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
BORGINI LUIGI
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
BORGOGNONI ROMEO
Pittore, figlio di Adolfo che era professore di letteratura presso l’ateneo
pavese, fu pittore conosciuto e professore della Civica scuola di pittura e
della Scuola d’arte applicata, entrò nella Loggia Cardano nel 1908.
Disegnò la lapide marmorea, in memoria di Carlo Ridella, da
murare presso la redazione del quotidiano, in Corso Mazzini, dove si trova
tutt'ora anche se purtroppo da tempo dimenticata. Per tale targa si indisse
una sottoscrizione che ammontò a lire 10.423,16. Venne solennemente inaugurata
nel III anniversario della morte il 20 settembre 1920.
BREGA ENRICO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
BREVENTANI GIUSEPPE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
C
CAIROLI BENEDETTO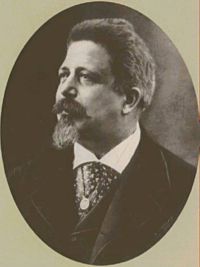
Nasce a Pavia il 28/1/1825
da Carlo (1776-1849), professore nella facoltà di medicina, rettore
dell'Università di Pavia
è podestà durante il Governo Provvisorio di Pavia (1848) e da Adelaide
Bono (1806-1871) figlia di un antico prefetto napoleonico milanese, poi conte
dell'Impero.
Primo di quattro
fratelli, accanto a loro anche due sorelle,
Rachele (1826-1856) ed
Emilia (1827-1856), da giovane,
studente di giurisprudenza (1849), ardente neo guelfo, partecipa nel marzo
1848 alla prima guerra d'indipendenza con altri volontari pavesi
 Nel
1850 aderisce, infatti, al partito mazziniano; propaganda, nel Pavese e nel
Mantovano, le cartelle del prestito nazionale ed entra a far parte del
Comitato rivoluzionario di Enrico Tazzoli.
Nel
1850 aderisce, infatti, al partito mazziniano; propaganda, nel Pavese e nel
Mantovano, le cartelle del prestito nazionale ed entra a far parte del
Comitato rivoluzionario di Enrico Tazzoli.
Scoperto, riesce,
tuttavia, a fuggire con Giovanni Acerbi e si rifugia in Piemonte. Aderisce al
comitato che coopera al moto mazziniano, subito represso, del 6/2/1853.
Cairoli si rifugia in
Svizzera, mentre l'Austria lo condanna per delitto d’alto tradimento.
In esilio, si convince
dell'inutilità' dei moti insurrezionali mazziniani e si accosta alla politica
piemontese. Questo gli
permette di tornare in Italia e di stabilirsi a Genova, dove, nel 1854,
stringe amicizia con Giuseppe Garibaldi. Allo scoppio della II guerra d'indipendenza nel 1859, coi fratelli
Enrico, massone, ed Ernesto, si arruola nel secondo Reggimento delle
Alpi e combatte valorosamente e nei combattimenti muore il fratello Ernesto.
Dopo il trattato di
Villafranca, può tornare nella sua città, Pavia, ormai libera dal dominio
austriaco. Partecipa attivamente ad organizzare nel 1860 la spedizione dei
Mille, raccogliendo, tra l'altro, una cospicua somma di denaro, che consegna a
Garibaldi. Egli stesso si unisce ai Mille e, con il grado di capitano della
settima compagnia, parte per la Sicilia. Combatte a Marsala e si distingue
nell'occupazione di Palermo, dove rimane gravemente ferito ad una gamba,
mentre il fratello Luigi, distintosi anche lui nell’impresa dei Mille, muore a
Napoli di tifo (1860).
Nel 1861, alla
proclamazione
del regno d'Italia, Benedetto è eletto
deputato.
La sua appartenenza alla massoneria, a volte messa in discussione, si
rileva, dalla lettera indirizzata al massone avv. Gian Luigi Bozzoni, Gran
Segretario del Grande Oriente d’Italia sedente a Palermo, in cui Cairoli si
firma con la tipica formula massonica dei tre puntini.

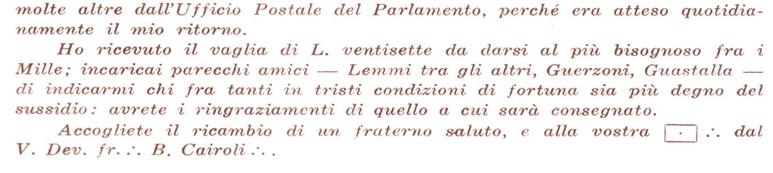
(Rass.
storica del Risorgimento, anno III,
fasc. III,
luglio-settembre 1865, pagg. 379-408)
A tutt'oggi operano, nel Grande Oriente
d’Italia - Palazzo Giustiniani, due Logge intestate a Cairoli e precisamente ad
Arezzo (B. Cairoli n.119) e a Bari (Cairoli Risorta n.777).
Esponente di
spicco nella Sinistra garibaldina, interviene varie volte nei dibattiti
parlamentari in favore della liberazione di Roma e Venezia; nel 1864, come
presidente del Comitato centrale unitario, continua a svolgere un'intensa
opera per legare polacchi ed ungheresi in un'azione comune contro l'Austria e
per abbattere il governo pontificio.
Nel 1863 contribuisce
alla caduta del gabinetto Rattazzi e,
dopo i fatti di Sarnico e dell'Aspromonte, si avvicina di nuovo a Mazzini,
aiutandolo nella cospirazione a favore della Polonia.
Nel 1866 fa parte della
commissione reale
per l'organizzazione dei volontari e, allo scoppio della III guerra d'Indipendenza,
parte per il fronte con i fratelli Enrico e Giovanni, massoni. Dopo
l'armistizio di Cormons e la pace di Vienna, riprende di nuovo il suo posto
alla Camera, stringendo ancora una volta i rapporti con Mazzini per accelerare
la conquista di Roma.
Nel 1867, quando il
Rattazzi risale al potere, Benedetto spera
in una politica favorevole alle sue aspirazioni, ma deve ben presto
ricredersi: i fatti di Mentana gli dimostrano l'indecisione del governo.
Rientra a
Pavia per consolare la madre duramente provata dalla morte di Enrico, caduto
valorosamente a Villa Glori, e da quella dell'ultimo figlio, Giovanni.
Allo scoppio della guerra
Franco-Prussiana (1870), Cairoli è in prima
linea nell'incitare il governo ad occupare Roma.
Negli anni successivi
partecipa poco ai lavori parlamentari e si dedica più intensamente alle cure
familiari, anche perché nel 1873 sposa la contessa Elena Sizzo
Noris
(1845-1920), erede di una
nobile famiglia trentina; preziosa confidente nell'impegno pubblico, che
s’impegna nell'ambito sociale con opere di solidarietà.
Nel 1876, quando la
Sinistra passa al potere con il Depretis (nato a Mezzana Corti - Pavia),
massone, Cairoli, originariamente, appoggia le sorti del nuovo governo poi
passa all'opposizione e contribuisce alla sua caduta, e succede, al Depretis,
come Presidente del Consiglio continuando, tuttavia, la sua politica estera.
Il 17/11/1878, Cairoli
viaggiando in carrozza con il re Umberto I, gli salva la vita, impedendo al Passanante di pugnalarlo, ma rimane ferito ad una coscia, e riceve dal sovrano,
motu proprio, la medaglia d'oro al valor militare.
al Passanante di pugnalarlo, ma rimane ferito ad una coscia, e riceve dal sovrano,
motu proprio, la medaglia d'oro al valor militare.
La sua popolarità aumenta,
ma, in seguito all'attentato, crescono anche le accuse alla sua
politica interna.
Il 19/12/1878 si dimette, ma
il 14/7/1879, nonostante le non buone
condizioni di salute, ritorna alla presidenza del Consiglio dei
Ministri ed assume anche il portafoglio degli Esteri e dell'Agricoltura.
E' un momento
particolarmente difficile
 per
l'Italia: i rapporti con l'Austria sono tesi per l'irredentismo, quelli con la
Francia assai complessi per la questione della Tunisia che la vicina nazione
intende conquistare. Il 12/5/1881 quando è reso pubblico il trattato del
Bardo, con cui è riconosciuto il protettorato della Francia sulla Tunisia dove
sono presenti cospicui interessi italiani, in tutti i circoli politici scoppia
un gran clamore che si ripercuote su tutto il Paese, aumentando il
malcontento e l'insoddisfazione della popolazione.
per
l'Italia: i rapporti con l'Austria sono tesi per l'irredentismo, quelli con la
Francia assai complessi per la questione della Tunisia che la vicina nazione
intende conquistare. Il 12/5/1881 quando è reso pubblico il trattato del
Bardo, con cui è riconosciuto il protettorato della Francia sulla Tunisia dove
sono presenti cospicui interessi italiani, in tutti i circoli politici scoppia
un gran clamore che si ripercuote su tutto il Paese, aumentando il
malcontento e l'insoddisfazione della popolazione.
Cairoli si dimette e si
ritira a vita privata. Trascorre, così, gli ultimi anni dedicandosi
alla famiglia e alla politica locale divenendo presidente del Consiglio
Provinciale di Pavia; insignito del Collare dell'Annunziata. Muore, ospite del
re, Umberto I, nella villa di Capodimonte a Napoli l'otto agosto 1889.
CALVI SANTE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
CAMERA EDOARDO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
CAMERA EMILIO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
CAMPARI ALESSANDRO
Presidente della Soc. A. Volta. Fu uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la
Società di cremazione di Pavia.
CAPELLA SILVIO
Membro della Loggia Pedotti. Orientamento politico estrema sinistra.
CASSI ANTONIO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
CASSOLA CARLO
Avvocato, garibaldino, una lapide commemorativa, posta in via Villa Glori, ne
ricorda le gesta e la sua partecipazione alle battaglie risorgimentali a fianco di Garibaldi.
Laureato in Giurisprudenza nell'ateneo pavese, di idee
mazziniane, fu uno dei duumviri, assieme a Luigi Contratti, che nel 1849
ressero Brescia liberatasi dalla guarnigione austriaca; il generale Nugent,
che si era asserragliato nella cittadella, morì negli scontri. Ma dopo poco
ritornarono le truppe imperiali rafforzate da nuovi contingenti, guidate dal
generale von Haynau, che per la ferocia del suo operato fu chiamato «Iena»
(con un gioco di assonanza sul suo cognome). Brescia, difesa da comuni
cittadini riforniti di poche armi e stremata dal fuoco nemico, si arrese
subendo ogni sorta di atrocità. Cassola, come molti altri combattenti per la
libertà, dovette riparare in esilio "e lo fece con molta eleganza: Si
limitò a vestirsi tutto di nero, a prendere a nolo una carrozza nera con
cocchiere in nero, e così si mescolò al corteo dei dolenti austriaci, che
accompagnavano alla sua tomba il Generale Nugent (quello che dalla rocca posta sulla collina che domina Brescia, aveva
bombardato la città)... All'altezza dell'ingresso
al cimitero, tutte le carrozze nere svoltarono ed entrarono, ma il
 nostro
Carlo fece invece proseguire la sua, e presto se
ne liberò, dirigendosi invece a piedi verso le
Alpi... In mezzo alla neve, ormai lasciato dal
contrabbandiere, che gli aveva indicato con la mano la direzione da seguire,
all'improvviso si trovò faccia a faccia con un orso: bello grande e ritto
sulle zampe di dietro. Si guardarono, e poi il
mio bisnonno, terrorizzato, si mise a cantare a gran voce un brano d'opera.
Questo spaventò l'orso, che scappò da una parte, mentre Carlo fuggiva
dall'altra!". Rimase qualche tempo a Capolago, in Svizzera, dove diede
alle stampe alcuni opuscoli, fra cui un resoconto delle eroiche dieci giornate
di Brescia (23 marzo-1 aprile 1849); poi si rifugiò a Londra e solo dopo
l'Unità tornò in Italia stabilendosi a Volterra, dove svolse l'attività di
magistrato. Ormai vecchio, tornò a Pavia. Il suo corpo fu richiesto dalla
città di Brescia perché fosse ospitato nel famedio degli eroi; qui tuttavia
non ha avuto l'onore atteso, poiché sul monumento non sono riportati i nomi
dei personaggi illustri che vi riposano e l'apparato scultoreo è in cattivo
stato di conservazione.
nostro
Carlo fece invece proseguire la sua, e presto se
ne liberò, dirigendosi invece a piedi verso le
Alpi... In mezzo alla neve, ormai lasciato dal
contrabbandiere, che gli aveva indicato con la mano la direzione da seguire,
all'improvviso si trovò faccia a faccia con un orso: bello grande e ritto
sulle zampe di dietro. Si guardarono, e poi il
mio bisnonno, terrorizzato, si mise a cantare a gran voce un brano d'opera.
Questo spaventò l'orso, che scappò da una parte, mentre Carlo fuggiva
dall'altra!". Rimase qualche tempo a Capolago, in Svizzera, dove diede
alle stampe alcuni opuscoli, fra cui un resoconto delle eroiche dieci giornate
di Brescia (23 marzo-1 aprile 1849); poi si rifugiò a Londra e solo dopo
l'Unità tornò in Italia stabilendosi a Volterra, dove svolse l'attività di
magistrato. Ormai vecchio, tornò a Pavia. Il suo corpo fu richiesto dalla
città di Brescia perché fosse ospitato nel famedio degli eroi; qui tuttavia
non ha avuto l'onore atteso, poiché sul monumento non sono riportati i nomi
dei personaggi illustri che vi riposano e l'apparato scultoreo è in cattivo
stato di conservazione.
E' il nonno dell'omonimo romanziere.

CERRI ANGELO
Socio accomandante della Officine Elettromeccaniche Ing.ri Einstein-Garrone &
C., alla fine dell’800.
CIAPESSONI PIERO
Professore
dell’Università di Pavia. Collegio Ghislieri. Dal 1907 al 1922. Membro della
Loggia Cardano di Pavia. Apprendista 1911, Maestro 1913, matricola G.O.I. n.
37666
DE AMBROSIS GIUSEPPE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
DE DOMINICIS SAVERIO FRANCESCO
Esponente del positivismo pedagogico e docente dell’ateneo pavese. Membro
della Loggia “Francesco Guardabassi” di Perugia che costituì con altri due
fratelli della stessa Loggia, Attilio Purgotti e Cesare Appendino, un
triangolo massonico per una ripresa dell’attività massonica in Pavia.
Fondatore della Loggia Cardano di Pavia.
DEPRETIS AGOSTINO
Nato a
Mezzana Corti Bottarone,
3 gennaio
1813 – deceduto a
Stradella, il
29 luglio
1887, statista italiano.
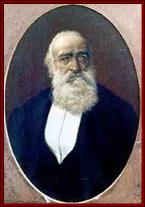
Fu
Presidente del
Consiglio dei Ministri Italiano per nove
mandati nei periodi:

Fin da
adolescente discepolo di
Mazzini e affiliato alla
Giovane Italia, prese parte attiva ai
moti mazziniani, tanto da rischiare la
cattura da parte degli Austriaci in occasione di un tentativo di far pervenire
armi agli insorti di
Milano. Dopo aver conseguito la laurea
in legge a Pavia, si adoperò per organizzare il movimento liberale nella
zona di Voghera. Eletto
deputato nel
1848 al parlamento subalpino per la
circoscrizione di Broni, aderì al gruppo della
Sinistra storica e fondò il giornale
Il Diritto, ma non rivestì cariche ufficiali fino a quando fu nominato
governatore di
Brescia nel
1859. Nel
1860 si recò in missione in
Sicilia per cercare di mediare fra le
posizioni di
Cavour, che spingeva per l'immediata
annessione dell'isola al
Regno d'Italia, e quella di
Garibaldi, che invece voleva rimandare
il
plebiscito di ratifica fino a dopo la
progettata liberazione di
Napoli e
Roma. Pur riuscendo a farsi nominare da
Garibaldi
dittatore pro-tempore della Sicilia, non riuscì tuttavia a concludere
l'accordo.
Dopo aver
accettato il dicastero dei Lavori Pubblici nel governo
Rattazzi del
1862, fece ancora da intermediario con
Garibaldi nell'organizzazione della disastrosa
spedizione dell'Aspromonte. Iniziato
alla Massoneria il 24 dicembre 1864, promosso compagno ed elevato al grado di
Maestro il 21 gennaio 1865, nella Loggia Dante Alighieri di Torino.
Quattro anni più tardi, allo scoppio delle ostilità con l'Austria,
entrò nel governo
Ricasoli come Ministro della
Marina. La sua decisione di mantenere al
comando della flotta l'ammiraglio
Persano contribuì non poco alla
sconfitta nella
Battaglia di Lissa del
1866. I suoi sostenitori, tuttavia,
sostennero, non senza fondamento, che, da civile inesperto di questioni
militari, non avrebbe mai potuto introdurre profondi cambiamenti
nell'organizzazione della flotta da guerra, e che quindi, nell'imminenza dello
scoppio delle ostilità, fu costretto ad accettare le scelte dei propri
predecessori. Su proposta del massone generale Federico Pescetto, il 21
gennaio 1868 venne affiliato alla Loggia "Universo", all'Oriente di Firenze
che in quel periodo era capitale del regno e che raccoglieva numerosi
parlamentari e notabili in attesa del riscatto di Roma.
Nel
1873, alla morte di Rattazzi, Depretis,
divenuto capo della
Sinistra, preparò l'avvento al potere
del suo partito, cosa che avvenne nel
1876, quando fu chiamato a formare il
primo governo di
sinistra del nuovo
Regno d'Italia. Elevato al 33° grado
del Rito Scozzese Antico ed Accettato ed eletto membro del Supremo Consiglio
il 15 gennaio 1877. Spodestato dal
Cairoli nel
marzo
1878 a causa dell'introduzione della
controversa
tassa sulle granaglie, il successivo
mese di
dicembre sconfisse Cairoli tornando ad
essere
Primo Ministro, ma, il
3 luglio
1879 fu ancora una volta estromesso
dallo stesso Cairoli. Nel
novembre del
1879, tuttavia, entrò a far parte del
governo Cairoli come Ministro dell'Interno, e, nel
maggio del
1881 gli subentrò come premier,
mantenendo la carica fino alla morte, avvenuta il
29 luglio
1887.
Durante
questo lungo intervallo di tempo compì ben quattro
rimpasti di governo, estromettendo
dapprima gli esponenti di sinistra
Zanardelli e
Beccarini, allo scopo di compiacere alle
richieste della
Destra, e successivamente nominando
Ricotti,
Robilant e altri esponenti conservatori,
attuando così quel rivolgimento politico che fu poi chiamato il
Trasformismo. Pochi mesi prima della
morte si pentì di aver compiuto queste scelte, e reintegrò Crispi e Zanardelli
nel proprio governo. Altre sue iniziative degne di nota furono l'abolizione
della sopra menzionata tassa sulle granaglie, l'ampliamento del
suffragio elettorale, il completamento
della rete ferroviaria, l'entrata nella
Triplice Alleanza e l'occupazione di
Massaua in
Eritrea, con cui si inaugurò la
politica coloniale dell'Italia.
Il 26 Novembre 2006
gli viene intitolata una Loggia all’Oriente di Voghera in provincia di Pavia
all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia con il numero distintivo 1279.
DE SILVESTRI AMILCARE
Fondatore della associazione di pubblica assistenza “CROCE VERDE”. Membro
della Loggia Cardano di Pavia.
FORNITI PARIDE
Direttore del giornale “La Provincia Pavese” e in seguito direttore del
giornale “La Provincia di Ferrara”. Membro della Loggia “Giuseppe Pedotti” di
Pavia.
FRANCHI AUSONIO
Fu professore di Storia della Filosofia a Pavia dal 1860 al 1863, prima di
essere trasferito all’Academia scientifico-letteraria di Milano. Fondò il Rito
Simbolico Italiano di Milano nel 1864 in antitesi al Grande Oriente D’Italia.
Alla base dello scisma l’esigenza di allargare le basi sociali della
fratellanza riducendo le tasse annuali e semplificando al massimo la complessa
ritualità massonica, con l’eliminazione degli alti gradi e la conservazione
dei soli gradi simbolici di Apprendista, Compagno e Maestro
L’ideale massonico di Ausonio Franchi si può così sintetizzare: ridurre ad una
sola famiglia l’umanità. Auspicava società di mutuo soccorso, istituti di
credito e stabilimenti industriali. Desiderva l’istruzione del popolo.
Politicamente, per lui, la massoneria doveva essere un campo neutro dove tutti
potessero incontrrsi per il bene comune. Di grande interesse notare che dal
gruppo di Ausonio Franchi facevano parte il banchiere Prospero Moisè Loria,
fondatore dell’Umanitaria di Milano, l’avvocato Giuliano Guastalla, il prof.
Avv. Luigi Cremona, il prof. Luigi Luzzati, il prof Ferdinando Dobelli.
GNOCCHI GUIDO
Medico, repubblicano, presidente dell’Istituto Sordomuti e assessore comunale;
nel 1892 fece parte della Commissione d’impianto della Camera del Lavoro
insieme ad un altro massone, G. Battista Pirolini, la nascita della Camera del
Lavoro locale fu, altresì, favorita dal massone Osvaldo Gnocchi Viani.
Assessore nell giunta presieduta dal sindaco prof. Pietro Pavesi, dal 1899 al
1902, nel 1887 entrò, con altri massoni : Emilio Beretta, Urbano Pavesi e
Antonio Grizzotti, nel comitato per la costituzione del ricreatorio laico
festivo di Pavia. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il titolo
distintivo “Giuseppe Pedotti”.
GNOCCHI LUCILIO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
GNOCCHI VIANI OSVALDO
Giornalista e scrittore politico, esponente nazionale di spicco dell’operaismo
vicino all’Internazionale, fu l’organizzatore delle forze operaie romane, in
seguito collaborò al giornale lodigiano “La Plebe”. Era stato segretario a
Pavia del fiorente Circolo democratico degli studenti.
GORINI ROBERTO
Avvocato, figlio di Paolo Gorini che era fisico e inventore sia del metodo di
conservazione delle salme sia del sistema per cremare i cadaveri e fu lo
stesso a sistemare, nel 1872, le spoglie di Mazzini. Membro della Loggia
“Giuseppe Pedotti” di Pavia. Ricompare, questa volta a Voghera, in una Loggia
“Pedotti”, faceva parte degli espulsi dal Grande Oriente d’Italia del 1898.
GRIZIOTTI ANTONIO
Avvocato, garibaldino, fu figura di spicco del movimento democratico pavese e
promosse la creazione del Museo del Risorgimento, Nel 1887 entrò, con altri
massoni : Emilio Beretta, Guido Gnocchi e Urbano Pavesi, nel comitato per la
costituzione del ricreatorio laico festivo di Pavia. nel 1873 fu tra i
firmatari, insieme ad altri massoni: Gaetano Manelli,, Giulio Turati e
Antonino Aragona, di una lettera contro i Gesuiti e contro l’inattività della
Sinistra. Fu uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione
di Pavia.
GUANGIROLI ERCOLE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
LAVEZZI PIERO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
LAVEZZI PIETRO
Avvocato, repubblicano intrasigente, membro della Società Democrtica. Fu uno
dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione di Pavia. Fu uno
dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione di Pavia.
Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il titolo distintivo
“Giuseppe Pedotti”.
MALAGUGINI ALCIDE
Professore di Lettere, fu sindaco socialista di Pavia dal 1920 al 1922, entrò
nella Loggia Cardano nel 1909. Membro della Loggia Cardano di Pavia.
MALINVERNI ARTURO
Fu Luigi, nato a Pavia il 13 agosto 1875, Medico Chirurgo. Fu fra rifondatori
della Loggia Cardano di Pavia.
MAMELI EFISIO
Professore di
Chimica nell’ateneo pavese, entrò nella Loggia Cardano nel 1909.
MANELLI GAETANO
Commerciante, volontario garibaldino, nel 1873 fu tra i firmatari, insieme ad
altri massoni:, Antonio Griziotti, Giulio Turati e Antonino Aragona, di una
lettera contro i Gesuiti e contro l’inattività della Sinistra. Fondatore, nel
20 settembre 1886 della Loggia con il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.
MANTOVANI COSTANTINO
Avvocato, Giornalista e uomo politico, redattore, nel 1899, del giornale
pavese “L’Avvenire”. Uno degli arrestati di Villa Ruffo nel 1873. Consigliere
e assessore comunale del Partito radicale. Membro della Loggia “Giuseppe
Pedotti” di Pavia della quale fu Maestro Venerabile.
 MANTOVANI GIUSEPPE
MANTOVANI GIUSEPPE
Membro della Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
A destra il Brevetto Massonico
MAROZZI FRANCESCO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
MAZZARELLI GIUSEPPE
Professore
dell’Università di Pavia. Scienze matematiche, fisiche e naturali. Dal 1900 al
1903. Membro della Loggia Cardano di Pavia. Proveniente dalla Loggia Losanna
all’Oriente di Napoli. Maestro 1899; matricoloa G.O.I. n.12164.
MONTINI CONTARDO
Fra i fondatori del giornale “La Provincia Pavese” insieme a Achille Bizzoni e
Costantino Mantovani (fratello di Giuseppe Mantovani, maestro venerabile della
Loggia Pedotti). Neo - giacobino. Fondatore del giornale "Canaglia". Fu uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di
cremazione di Pavia.
MORONE GIOVANNI
Illustre accademico, Medicina e chirurgia,. Dal 1911 al 1922. Nel 1926 ottenne
la cattedra di Patologia Chirurgica nell’Università di Siena, in seguito, nel
1931, fu chiamato allo stesso incarico a Pavia, nel 1934 passò alla cattedra
di Clinica Chirurgica, incarico che tenne sino al 1950. Con Morone si sono
continuate le piú alte tradizioni della scuola chirurgica pavese, entrò nella
Loggia Cardano. Apprendista 1915, Maestro 1916; matricola G.O.I. n. 47198.
MUSSINI ERCOLE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
OEHL GIULIO
Professore dell’Università di Pavia. Socio fondatore, con l’Ing. Paolino
Moncalvi, l’Ing. Mario Cozzi e Gaicomo Aprile, nel 1905, della Ing. Moncalvi &
C.
PAVESI URBANO
Possidente Ingegnere, nato ad Albuzzano il 27 Agosto 1842, soldato volontario
nell’esercito piemontese del 1859, poi seguace di Garibaldi con l schiera dei
mille nel 1860 e nella campagna del 1866. Cospirò in Roma con altri pavesi nel
1867, sfuggendo, miracolosamente alle ricerche della polizia pontificia.
Fu consigliere comunale e ricoprì diversi incarichi pubblici tra i quali la
presidenza della commissione per il civico museo del Risorgimento; nel 1887
entrò, con altri massoni : Emilio Beretta, Guido Gnocchi e Antonio Grizzotti,
nel comitato per la costituzione del ricreatorio laico festivo di Pavia. Fu
uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione di Pavia.
Il 27 Aprile 1907 muore in Pavia, commemorato dai Prof. Pavesi, Roncani,
Benini, Fossati e Rampoldi, e dai giornali cittadini ricordato con onore; fu
cittadino devoto in ogni tempo alla causa nazionale e a Pavia, a cui, nei
molti uffici pubblici ai quli venne eletto, diede l’opera sua disinteressata e
prudente.
Il 3 Maggio 1908 nel civico Museo del patrio Risorgimento si inaugura un
ricordo marmoreo al patriotta pavese ingegnere Urbano Pavesi.
PIANETTA CESARE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
PIROLINI GIAN BATTISTA
Direttore del giornale “La Provincia Pavese” nel 1892 e nello stesso anno fece
parte della Commissione d’impianto della Camera del Lavoro insieme ad un altro
massone, Guido Gnocchi, la nascita della Camera del Lavoro locale fu, altresì,
favorita dal massone Osvaldo Gnocchi Viani .
PIROLINI GIOVAN BATTISTA
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
PODERINI ARCHIA
Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.
Membro della Loggia "Cardano". Esponente della "Società democratica radicale
Felice Cavallotti"
PREDIERI ENRICO
Avvocato, dal 1899 al 1902 fu assessore nella giunta presieduta dal sindaco
prof. Pietro Pavesi.
RICOTTI GIOVANNI
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
RIDELLA CARLO
 Avvocato
e interventista, entrò nella Loggia Cardano nel 1911.
Direttore del giornale "La Provincia Pavese". Coerente con le idee
più volte espresse dalle colonne del suo giornale si arruolò volontario
nella Grande Guerra. Decorato al valor militare, morì in trincea a Versic
Korite nel 1917.Membro della Loggia "Cardano" dal 1911.
Avvocato
e interventista, entrò nella Loggia Cardano nel 1911.
Direttore del giornale "La Provincia Pavese". Coerente con le idee
più volte espresse dalle colonne del suo giornale si arruolò volontario
nella Grande Guerra. Decorato al valor militare, morì in trincea a Versic
Korite nel 1917.Membro della Loggia "Cardano" dal 1911.
RIMINI ENRICO
Professore di
Chimica nell’ateneo pavese dal 1910 al 1917.
ROSSI PAOLO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
ROVIDA CARLO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
SCAPOLLA ANTONIO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
SCURI ENRICO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
SINFORIANI ITALO
Esponente della "Società democratica radicale
Felice Cavallotti".
SPALLA LUIGI
Fu fra i
fondatori, nel 1871, del circolo mazzinino “Pensiero e Azione”.
SPELTA
Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.
Membro della Loggia "Cardano"
SUALI LUIGI
Professore
dell’Università di Pavia. Lettere e filosofia. Dal 1909 al 1922. Membro della
Loggia Cardano di Pavia. Apprendista 1909, Maestro 1912; matricola G.O.I. n.
30650.
TACCHINI ACHILLE
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
TOLLINI MARIO
Fotografo. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il titolo
distintivo “Giuseppe Pedotti”.
TURATI GIULIO EMILIO
Scrivano, nato a Pavia il 19 Aprile 1843, garibaldino, fu membro della Società
Cooperativa di Consumo, nel 1873 fu tra i firmatari, insieme ad altri massoni:
Antonio Griziotti, Gaetano Manelli e Antonino Aragona, di una lettera contro i
Gesuiti e contro l’inattività della Sinistra. Fondatore, nel 20 settembre 1886
della Loggia con il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.
VALENTI
Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.
Membro della Loggia "Cardano"
VALLE GAETANO
Possidente, presidente della Società operaia di Redavalle (PV). Fondatore, nel
20 settembre 1886 della Loggia con il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.
VARASI ERNESTO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
VENERONI EMILIO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
VENINI GAETANO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
VIGONI ALFONSO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.
VITTADINI PIETRO
Membro della
Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.